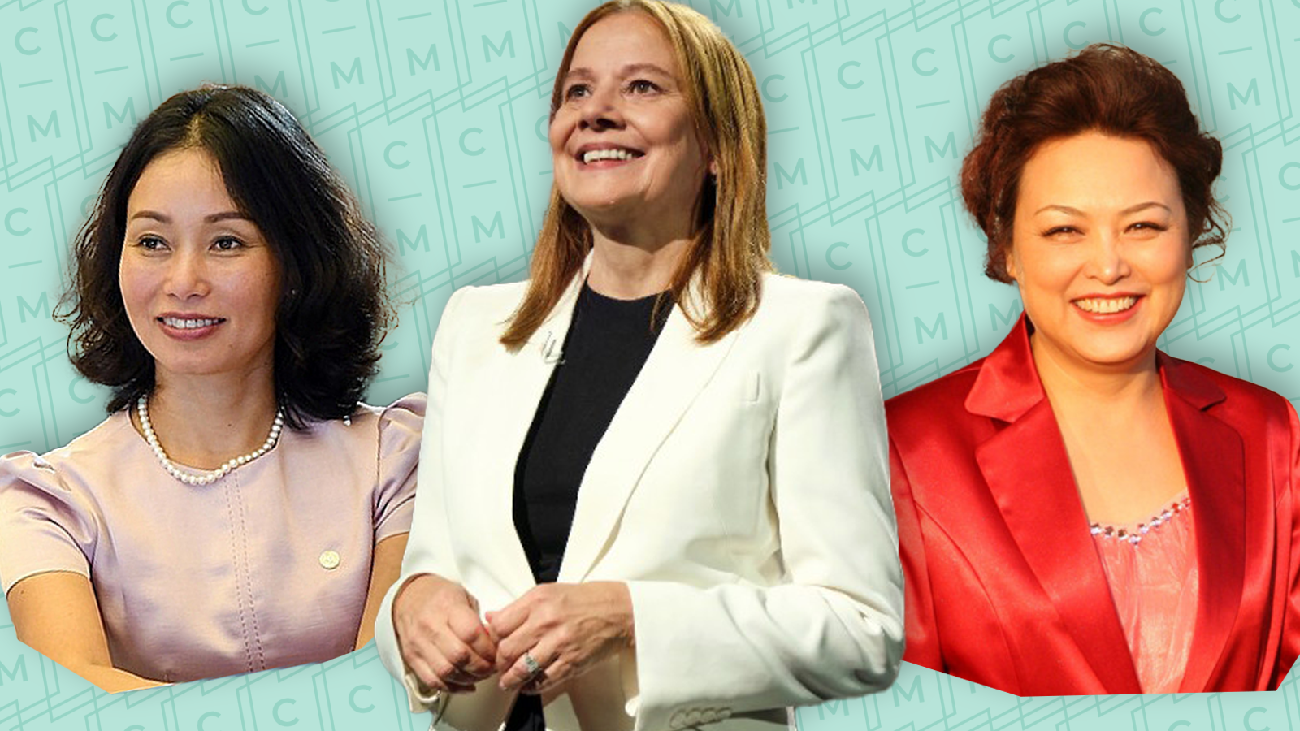Una volta finito ci mise un po’ a riprendersi.
Restò lì qualche momento a osservarsi: prima la punta delle dita, poi le mani, poi il riflesso del viso. Senza mai riuscire davvero a metterli a fuoco. A mettersi a fuoco. Sfiorava le cose con lo sguardo liquido di un maratoneta a fine gara: col fiato corto si concentrava ora su questo, ora su quel particolare, ma falliva miseramente nel ricostruire il quadro nella sua interezza.
Non che vi stesse dedicando chissà quanta energia.
Dopo un paio di minuti era ancora lì, sulla stessa sedia, nella stessa posizione di quando aveva messo un punto a quella storiaccia e se l’era lasciata alle spalle. Ma il sollievo tardava ad arrivare, e continuava a sentirsi perso nella nebbia, incapace di scrollarsi di dosso pensieri e ricordi da cui – finalmente – avrebbe potuto permettersi di allontanarsi. Era da un po’ che non gli capitava così.
Diede uno sguardo sconsolato alla finestra e poi si alzò di scatto. Un passo era fatto. Peccato si sentisse subito esausto, spompato. Si diresse allora mogio verso i fornelli e – con una lentezza che, per esperienza, sapeva molti avrebbero reputato inaccettabile – si preparò un caffè che sperava lo avrebbe scosso da quel torpore. Ma ogni gesto era più lento e impreciso del necessario: l’acqua del rubinetto scorse troppo a lungo e sbrodò dalla caldaia, mise troppo caffè nel filtro e questo andò a spargersi sul piano della cucina, mescolandosi irrimediabilmente con l’acqua di cui sopra, e la caffettiera la strinse, sì, ma senza troppa convinzione. Sicuramente non avrebbe tenuto granché. Che disastro: se la signorina Sonia l’avesse visto in quel momento avrebbe scosso la testa con pena, lei che aveva sempre promosso e ostentato un cucinare preciso e privo di sbavature. Si sentì in colpa. Quella donna di mezza età, posata e misurata in ogni gesto, risvegliava in lui un insopprimibile senso di inadeguatezza e inferiorità. Sbuffò e con riflesso stizzito cominciò a ripulire il bancone, con perizia. Di nuovo, si stava perdendo di nuovo.
Il suono di una notifica sullo smartphone lo riportò in sé.
Tremò al pensiero che fosse ancora qualcosa che potesse riguardare quello: se n’era appena liberato e il pensiero di dover ripiombare in quell’incubo gli provocò una vertigine. Non vedeva l’ora di tagliarci i ponti una volta per tutte, con lui e il suo giro di “amici”. Gli facevano ribrezzo, e col senno di poi non capiva come potesse esserci cascato: il gioco non valeva la candela. Certo: qualche scartoffia e un po’ di burocrazia e avrebbe potuto voltare pagina, sempre che non si fosse di nuovo fatto incantare. Ma si incupì all’idea di un potenziale prolungarsi della fase di distacco. Energie sprecate: era un SMS sgrammaticato di sua madre.
“NONNO VIENE a cena . Tu che fai pure vieni?”
Represse la voglia di correggerla – ancora una volta – e ripensò alla risposta piccata che lei gli avrebbe sbattuto in faccia di fronte all’ennesima interferenza: “Non ti pago mica per farlo, eh!”. Per altro, aveva ragione: era un tipo di arroganza gratuita che, per fortuna, non doveva più interpretare.
L’ironia della cosa però non lo lasciò indifferente: se i suoi colleghi l’avessero visto, quel testo sbilenco, si sarebbero di certo chiesti da dove fosse venuta fuori tutta la precisione che andava “sfoggiando come un gagliardetto”. Secondo loro, quanto meno. Come se avesse potuto scegliere di fare diversamente, di essere diversamente. Impossibile. E sì che ci aveva provato, quando il lavoro aveva cominciato a influire negativamente sulla sua vita privata, e le battute erano
diventate commenti sprezzanti e i commenti sprezzanti furiose guerre del silenzio, e tutto era finito.
La caffettiera fischiò malamente, vomitando dalle giunture rivoli di caffè sui fornelli, come previsto. Si perse a guardarla un attimo, poi spense il fuoco, prese una tazza e se lo versò sciabattando sbiadito fino al terrazzino. Di Rosa in casa erano rimaste solo poche piante lasciate lì per dimenticanza – o forse per ripicca: “Almeno queste cerca di non farle morire” s’era immaginato più volte potesse avergli urlato contro durante una lite desiderata e mai esistita – e appassite invece quasi tutte, una dopo l’altra, per sfortuna o per incuria nelle settimane in cui il lavoro aveva preso il sopravvento, lo aveva assorbito, e gli aveva rubato lo spazio per i pensieri di ogni giorno. Come succedeva spesso. Come era successo con lei.
“Non ti riconosco più”.
Un bigliettino verde a forma di foglia, poggiato al centro del tavolo. Se n’era andata così, svuotando la casa e mettendo fine a due anni di convivenza con venti caratteri spazi inclusi, come in un brutto film americano, e lui non aveva potuto rispondere né avrebbe saputo cosa dirle, perché capiva bene che – inutile negarlo – lei aveva fatto
la scelta giusta. Quando non c’è più nulla da dire è meglio il silenzio. E più che la fine della sua relazione con Rosa ad averlo ferito fu che, di nuovo, le parole gli si erano rivoltate contro, e lo avevano trafitto, lui che con le parole ci lavorava. Non solo gli venivano meno ogni volta che ne aveva bisogno lui, proprio lui, ma lo avevano avvelenato, lentamente, gli avevano confuso l’identità, i pensieri, i desideri, i valori. Più bravo diventava a dare voce agli altri, meno risultava capace di esprimere se stesso, e questo Rosa aveva iniziato prima a notarlo, poi a riderci sopra, poi a provare a riderci sopra e infine a non sopportarlo più.
Che gagliardetto era, quindi? L’avrebbe chiesto volentieri ai suoi colleghi, fosse stato meno riservato sulla sua vita privata. Come avrebbe raccontato loro che più volte aveva provato ad allontanarsi da questo supplizio di Tantalo e più volte invece c’era ripiombato dentro, ancora e ancora, nonostante tutto anche per colpa loro, grazie al passaparola – per l’ennesima volta: quanta ironia – di clienti soddisfatti che si dichiaravano con orgoglio “perfettamente rappresentati”. Beati loro. E ogni progetto era più grosso, e importante, e totalizzante del precedente, e lui diventava altro, diventava un altro, ed era poi sempre più difficile liberarsene e regalarsi un po’ di ossigeno.
“All’ora?”.
L’SMS anticlimatico di sua madre, pur tristemente consapevole che provare a contattarlo durante una commessa era tutt’al più una perdita di tempo, lo liberò da quelle sabbie mobili di agitazioni e ansie in cui s’era volontariamente incamminato e lo lasciò nuovamente perso e boccheggiante come dopo un amplesso spezzato a metà. Si ritrovò a guardare lo scheletro smunto della pianta di margherite che, testarda, per qualche motivo si ostinava alla vita come sua madre a pretendere una risposta, e si ripromise sconfitto che almeno una delle due cose l’avrebbe risolta.
Quella sera aveva già una cena in programma, per il compleanno di un vecchio amico, e l’obbligo ad attendervi lo avrebbe schermato da ogni senso di colpa. Sarebbe bastata una chiamata rapida.
La vista del salotto dal terrazzino lo distrasse dal proposito. I muri bianchi ormai spogli e l’arredamento minimal copiato dalle riviste di architettura contrastavano col caos figlio di una settimana di lavoro troppo intensa e di un nichilismo che si protraeva ormai da ben più tempo. Si fece pena: i suoi ripetuti tentativi di risalire la china e ridarsi una forma in cui si potesse riconoscere non avevano dato alcun risultato. Pure il poster motivazionale – acquistato sull’onda lunga di un lavoro fatto per un mental coach e messo al centro di una parete vuota con una logica che ora pareva sfuggirgli – se ne stava lì immobile in cordoglio, testimone del suo fallimento.
“Cambia i tuoi pensieri e cambierai il tuo mondo”.
Quella frase in una bella grafia fiorita dai colori pastello ora gli pareva beffarda, quasi offensiva. Su quali pensieri avrebbe dovuto concentrarsi? Su quelli dell’ecologista indefesso, della madre prima che imprenditrice, del medico con i pazienti sempre al primo posto, di quello, della signorina Sonia, dell’amministratore della banca coi valori? Su quali? “Tuoi” e “tuo” gli ronzavano intorno e lo pungevano fastidiose, una, due, cento volte ma lui non riusciva più ad afferrarle e a imbastirci qualcosa che gli calzasse addosso come un bell’abito, che sentisse suo e solo suo, ogni alternativa gli sembrava roba pensata per altri, già usata da altri e provò rabbia. Provò rabbia. Avrebbe voluto essere come Michelangelo, Botticelli, il Mantegna, persino Picasso, che a loro stessi non avevano rinunciato mai e che avevano lasciato tracce di sé, del loro volto, della loro identità in molte delle proprie opere. Perché con lui succedeva il contrario? Perché i frutti della sua immaginazione gli si appiccicavano addosso come melma e gli toglievano forma e dignità? Si immaginava come un foglio bianco, privo di contenuto. Un vaso vuoto. Si chiese cosa avrebbe mai potuto fare uno che, a ruoli invertiti, si fosse trovato costretto a scrivere di lui. Come ne sarebbe uscito?
Si mise nervosamente a raccogliere e riordinare le riviste, ad accartocciare e buttare i quotidiani che aveva usato come riferimento nei precedenti giorni di lavoro, a svuotare i piatti accumulati dai residui di cibo e a buttarli in lavastoviglie, e gli sembrava che finalmente almeno le sue mani avessero di nuovo un contorno, gesto dopo gesto, mentre prendevano e spostavano e distruggevano e rassettavano e schiacciavano e smistavano, e che quella rabbia partendo dalle dita pian piano lo stesse riempiendo come acqua con un palloncino, che stesse colmando gli spazi vuoti fra le molecole del suo corpo, si sentiva finalmente sostanza concreta, carne viva, gli sembrava di percepire il sangue che gli correva nelle vene e ridava colore alla pelle. E neanche il suono del citofono fermò l’esaltazione, nemmeno Francesco
che entrò in casa e si sedette placido sul divano ad aspettare che l’amico fosse pronto. Non gli disse nemmeno una parola, bastò uno sguardo a mendicare un po’ di pazienza – si conoscevano da molto – mentre prima le braccia, poi il busto, poi le gambe ritrovavano un contorno. Osservò con soddisfazione i suoi piedi spostarsi in camera da letto, le mani afferrare dei vestiti puliti e indossarli, la sua testa, proprio la sua, fare capolino dalla t-shirt e di fronte allo specchio mise finalmente a fuoco i suoi occhi. Eccoli. Come in una personale epifania, prese una decisione. Indossò le
scarpe e tornò in sala.
“Scrivi tu il messaggio d’auguri anche per me, che sei più bravo?”.
Francesco lo aspettava sulla porta della camera. Lui lo guardò interdetto, mentre l’amico gli metteva una penna in mano e lo spingeva verso il tavolo.
“Dai su che siamo in ritardo”.
Avrebbe voluto fermarlo, raccontargli, spiegargli, ma ancora una volta le parole erano scappate via, forse ridevano di lui. Chissà. Davanti al chiassoso bigliettino d’auguri scelto dall’amico, con quella penna in mano, senti ancora una volta i suoi contorni farsi flebili, sbiadirsi e diluirsi, la rabbia scemare, le risoluzioni svanire. Si stava perdendo di nuovo. Guardò il bigliettino, guardò la penna, trattene il respirò e cominciò.