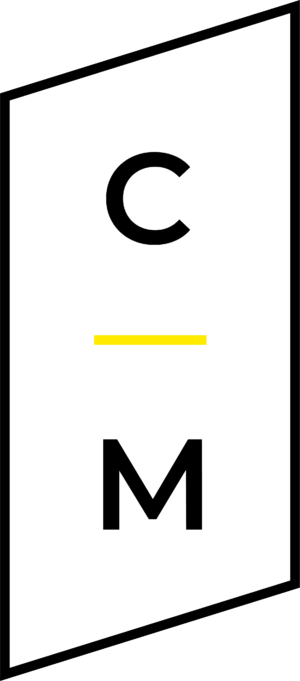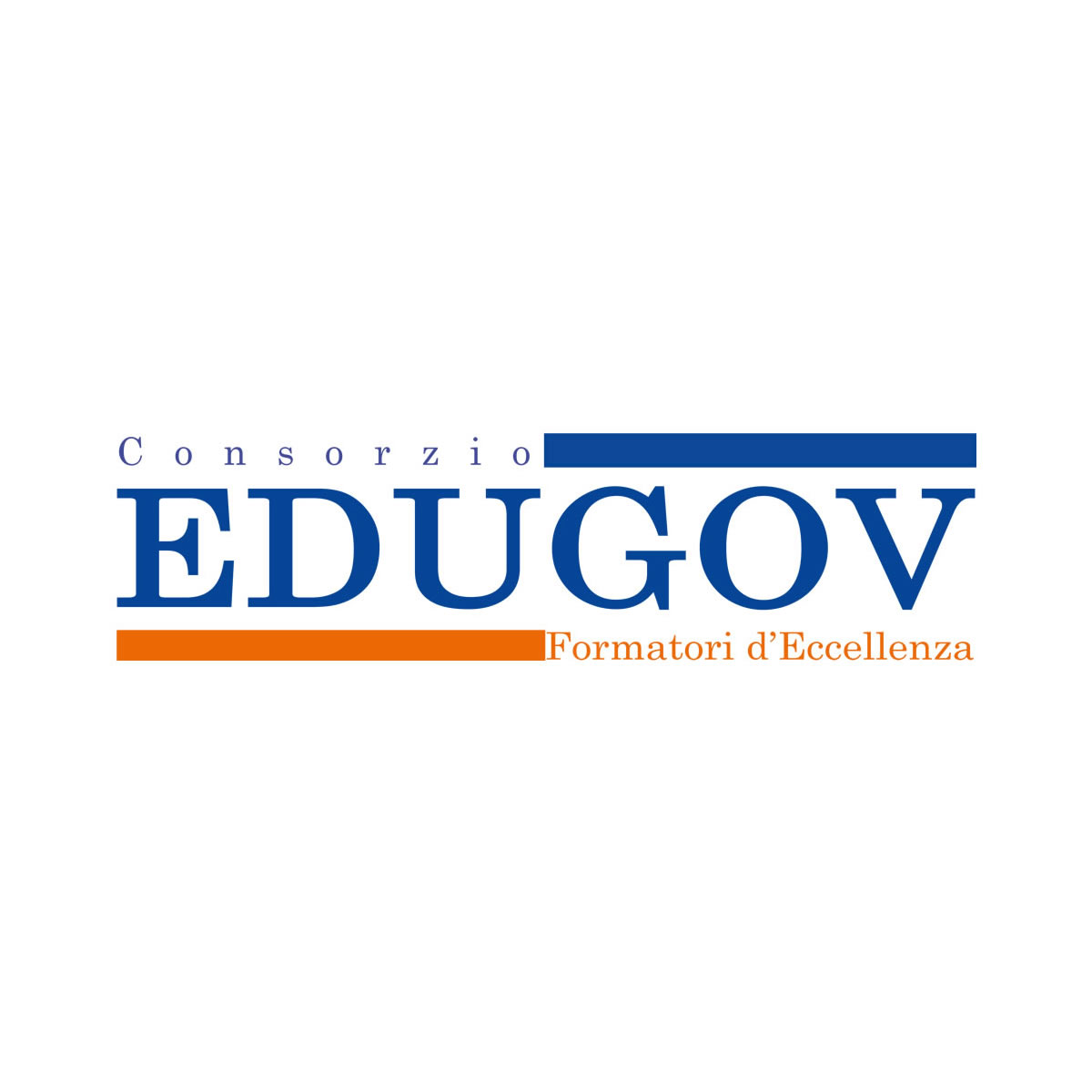[Di questo post, due giorni fa, avevo scritto un lungo testo. Non mi convinceva. L’ho messo da parte, e l’ho riscritto: una comunicazione efficace è una comunicazione consapevole, volontaria, capace di riconoscere anche i messaggi veicolati in maniera non intenzionale. Non sempre è possibile – siamo esseri umani, non macchine – ma quando succede, bisogna sempre darsi ascolto.]
–
Il personal branding è un’attività di marketing che lavora sull’individuo. In sostanza, fa con le persone quello che il branding realizza con le aziende: evidenziare l’unicità e le particolarità di un soggetto rispetto a tutti gli altri soggetti presenti all’interno di un mercato competitivo.
Definizione noiosa? Sì.
Semplifichiamo: il personal branding è il modo con cui una persona si presenta agli altri. Una vetrina di ciò che un individuo vuole far vedere di se stesso.
È un’attività che ciascuno di noi porta avanti sempre, che ne sia consapevole o meno. In ogni momento della nostra vita, con ogni scelta che operiamo: come tendo a ripetere (eccessivamente) durante i miei corsi, “tutto è comunicazione, tutto comunica qualcosa”. Il modo in cui ci vestiamo, pettiniamo, trucchiamo, gli oggetti che acquistiamo e quelli che usiamo quotidianamente, le parole che pronunciamo e quelle che non pronunciamo, il modo in cui scriviamo, le relazioni che intrecciamo. Tutti questi elementi raccontano qualcosa di noi, raccontano la nostra storia.
Il personal branding fa sì che tutte queste scelte avvengano in maniera intenzionale, determinata: come dice Wikipedia – nella voce in lingua inglese, molto meglio scritta di quella in italiano – si tratta di una forma di “self-packaging”, di “inscatolamento del prodotto”. E il prodotto siamo noi.
Dal “personal branding” alla “narrazione di sé”
Per anni, io e Domitilla Ferrari abbiamo costruito il nostro rapporto di amicizia su un gentlemen’s disagreement relativo alle sempre più diffuse pratiche di applicazione del personal branding: io lo vedevo come fumo negli occhi, lei con molta più fascinazione. Ora che non sono più né giovane né estremista nelle opinioni, devo concederle la vittoria: nel personal branding non c’è nulla di male, di per sé. Con qualche distinguo.
Il problema – dal mio punto di vista – è di concetto, di approccio e terminologico.
- Di concetto, perché l’idea che si possa costruire a tavolino una identità personale è… fondamentalmente sbagliata: la nostra identità è figlia di un processo culturale, personale e storico che stratifica tutte le esperienze, i contesti e le relazioni che hanno costrellato la nostra vita. Pretendere di voler mostrare una caratteristica personale che non fa parte del nostro mindset, o di nascondere completamente un difetto che è parte di noi, ci espone all’incoerenza. E nessuno con coscienza si affiderebbe a una persona incoerente, sul lavoro e nella vita privata.
- Di approccio, perché – stante quanto sopra – non ha alcun senso partire dal risultato finale che si pretende di ottenere perché percepito più efficace o maggiormente di successo (come tanti Guru del Personal Branding e Motivatori Della Rete pretendono di fare). Si deve, semmai, partire da una analisi personale e quanto più brutalmente onesta possibile, in positivo e in negativo: partire dall’as is, come dicono quelli bravi con il linguaggio imprenditoriale, e da lì comprendere come raccontare se stessi, non cosa raccontare di se stessi.
- Terminologico, perché il termine “personal branding” si è ormai stratificato nel nostro linguaggio e nella nostra cultura più come sofisticazione che come racconto.
Per queste ragioni più che di “personal branding” preferisco parlare di controllo della narrazione di sé. Un processo basato su scelte coscienti, a loro volta basate su autoconsapevolezza e accettazione personale. Non per creare filtri e barriere, ma per far sì che TUTTO ciò che sono – accento su “tutto – venga comunicato in maniera comprensibile e contestualizzata.
Questione di sfumature, per qualcuno. Ma che fanno la differenza.
Personale, professionale e lavoro
Facciamo un esempio pratico: io.
Non sono una persona asettica nei rapporti umani. Anche sul lavoro sono una persona che applica le sue competenze mantenendo un rapporto empatico con colleghi, superiori, committenti, studenti. È un difetto? No. Ma ci sono persone che invece associano la professionalità a una certa separazione fra l’uomo e la sua attività lavorativa.
Se dovessi seguire i dettami del personal branding attuale, dovrei presentarmi al pubblico in una maniera “tradizionalmente” professionale: giacca e cravatta, linguaggio tecnico e numerico, pochi fronzoli. Una comunicazione statica, granitica. Funzionale al raggiungimento di un target esteso. Che non sarebbe però coerente con quello che poi offrirei io al mio cliente.
Qui entra in gioco invece il controllo della narrazione: anziché millantare caratteristiche che non mi appartengono, posso fornire strumenti interpretativi per aiutare il pubblico a comprendere come ciò che sono può venirgli utile. Posso smontare l’equazione “rigoroso = professionale”. Posso sottolineare l’importanza dell’empatia nel trovare soluzioni condivise a problemi complessi. Posso enfatizzare le fondamenta relazionali di qualsiasi attività comunicativa.
È quello che ho appena fatto, per intenderci, con voi che avete letto fin qui.
Niente di quanto descritto finora è semplice. Si tratta di uno sforzo cosciente, continuo e – come già detto – consapevole. Va portato avanti con misura, rispettando l’interlocutore e la sua intelligenza. Deve essere una comunicazione informativa, non manipolatoria (a proposito: sul tema c’è molto da dire, lo aggiungo alla mia to-do list). Deve fornire valore che vada oltre l’autopromozione. E soprattutto deve essere coerente, coerente, coerente: con il soggetto della comunicazione, con il contesto della comunicazione e nel corso del tempo.
Non è facile.
Ma se comunicare bene fosse facile, tutti sarebbero in grado di farlo e noi vivremmo in un mondo migliore. Decisamente migliore.